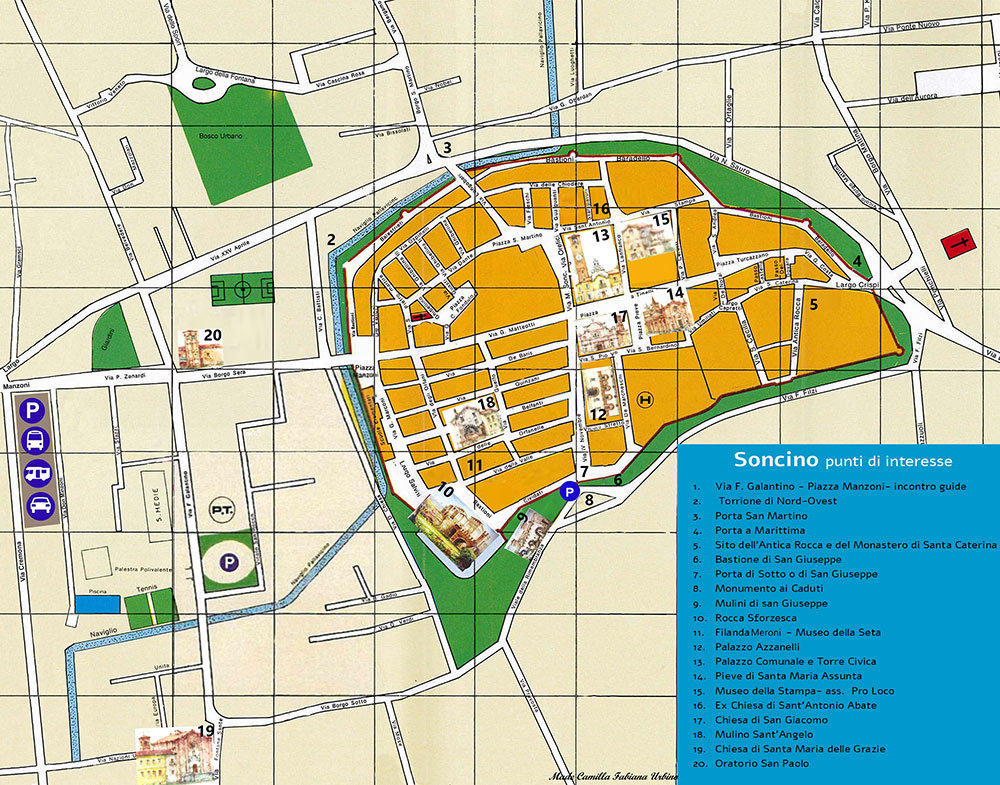Visita Soncino
Il Borgo medioevale
Nei pressi della Rocca sorge l’ex filanda Meroni, edificata nel 1898 con caratteri eclettici tipici dell'architettura tardo-ottocentesca; proseguendo, giungiamo alla Porta a Sera ed entriamo nel borgo per via IV Novembre, l'antica Strada Magna (Contrada Grande) che ne costituisce l'asse principale. Il tessuto urbano rivela la sua conformazione tipicamente medioevale con case e palazzi allineati lungo la strada.
Palazzo degli Azzanelli
Quattrocentesco è il risultato della trasformazione di un precedente palazzo acquistato dalla famiglia di mercanti soncinesi. Il Palazzo presenta un'elegante facciata decorata da monofore trilobate in cotto con putti e modanature a tortiglione decorata da festoni, ghirlande e putti reggighirlanda. Un tempo il Palazzo presentava una ricca decorazione costituita da piastrelle in ceramica policroma.
Palazzo Zardina-Cropello
Questo Palazzo, posto nelle vicinanze del Palazzo Azzanelli, è il risultato di una vasta ristrutturazione tardo settecentesca dell'antico Ospedale dei Pellegrini che ha inglobato il "Quartiere Barbò", arsenale privato della nobile famiglia, di cui è possibile ammirare la torre, rimaneggiata, posta all'angolo del fabbricato. Quest'ultima si presenta con facciata in cotto ingentilita da due bifore strombate al piano nobile.
Palazzo Bobbio-Tonsi
Questo Palazzo è l'unico ad aver conservato l'originaria struttura del portico terreno con quattro archi acuti.
Palazzo Barbò-Cropello
Edificato dalla nobile famiglia cremonese, venne ampiamente rimaneggiato nel XVIII secolo ed in seguito adibito ad osteria grande della Comunità e fornaio. Nella parte terminale della strada è possibile ammirare la lunga teoria di portici sotto cui si aprivano le botteghe. Nelle vicinanze, in via De Baris, è possibile ammirare un bel cortile quattrocentesco denominato "Enoteca I cinque frati".
Palazzo Comunale
Posto nella piazza del borgo, il Palazzo comunale, quale lo vediamo oggi, si presenta come una serie di ricostruzioni, aggiunte e demolizioni. Il palazzo è cresciuto nei secoli con l'aggiunta di diversi corpi di fabbrica. La Torre civica ed il Palazzo Vecchio risalgono al XII secolo, il Palazzo dei Consoli, in seguito inglobato nel Palazzo Comunale risale alla seconda metà del XII secolo, il Palazzo del Podestà, della metà del XIII secolo ed infine il Palazzo Nuovo che chiude il lato sud della piazza, eretto nel XV secolo. La Torre delle ore presenta alla sommità due automi, aggiunti nel 1506 dal governo veneziano. Il Palazzo del Podestà venne distrutto nel 1802 da un terremoto La Torre civica venne costruita nel 1128, a canna quadrata; nel 1575 venne rialzata sino alla quota attuale di 41,80m. Secondo la tradizione, nel Palazzo venne rinchiuso Ezzelino da Romano. All'interno il Palazzo ospita la bella sala della Giunta impreziosita da un arredo ligneo, l'Archivio storico con documenti dal 1311 ai giorni nostri ed una quadreria. In quest'ultima segnaliamo il Cristo Crocifisso, opera del cremonese Giulio Calvi detto il Coronaro, proveniente dalla chiesa di S. Giacomo; l'Immacolata tra S. Bernardino ed il Beato Pacifico Ramati, opera settecentesca del milanese Federico Ferrario.
Via Sant'Antonio
Lungo la via Sant'Antonio possiamo ammirare una sequenza di antichi edifici del XV secolo che hanno mantenuto inalterati i loro caratteri architettonici: l'ex-chiesa di S. Antonio, il Palazzo del Monte di Pietà, l'Ospedale di S. Antonio e l'edificio che ospita il Museo della Stampa. Le fronti sono caratterizzate da finestre strombate e portali con archi ogivali. L'Ospedale di S. Antonio venne fondato nel 1240 dal Beato Facio da Verona Di fianco all'ospedale venne fondata pure la chiesa dedicata prima allo Spirito Santo ed in seguito a S. Facio, in onore del fondatore dell'Ospedale, indi a S. Antonio Abate. Qui sorgeva pure il Monte di Pietà, fondato nel 1472 dal francescano Pacifico Ramati da Cerano.
Palazzo Covi
Questo palazzo sorge in piazza S. Martino, sulla quale prospetta pure la Loggia Comunale, eretta nel 1879 e denominata Portico Rosso, a causa del colore dei mattoni della pavimentazione. La loggia presenta tre archi decorati da bugne. Le pareti sono ornate da bassorilievi in cotto raffiguranti i Mesi, i Mestieri ed i giochi d'infanzia. Le formelle sono opere recenti realizzate dagli allievi dalla Scuola di Artigianato d'Arte. Sul lato settentrionale della piazza vi sono due palazzi settecenteschi con portico e loggiato. il Palazzo Covi, già dimora della nobile famiglia soncinate, presenta, seppur rimaneggiato, l'originario apparato decorativo in cotto con fregi, cornici e formelle di epoca rinascimentale. Anche le finestre presentano cornici in cotto, come pure in cotto è la cornice marcapiano, decorata con motivi classici ad ovuli, dentelli ed archetti intrecciati oltre ad una serie di putti inginocchiati che reggono festoni e ghirlande con lo stemma della famiglia.
Teatro Comunale
Il Teatro Comunale, attualmente sede della Biblioteca Comunale, venne edificato nel 1791, ma la facciata attuale, in stile liberty, è il risultato della trasformazione avvenuta agli inizi del secolo scorso.
Palazzo Galantino
Eretto all'inizio del XVIII secolo, il Palazzo Galantino presenta una sobria facciata d'impianto classico. Di fronte sorge il complesso dell'ex-convento dei SS. Paolo e Caterina, fondato dalla Beata Stefana Quinzani nel 1508. Soppresso nel 1784, la chiesa venne ridotta a cappella privata della famiglia Galantino. La chiesa pubblica venne trasformata in sala teatrale.
La Rocca sforzesca
Fu il degrado in cui versava l’antica rocca di sud-est, prima costruzione militare a difesa del borgo risalente al X secolo, a determinare il duca Galeazzo Maria Sforza ad erigere una nuova rocca a sud-ovest.. La torre a base circolare di sud-ovest è frutto dell’adattamento del preesistente torrione.. I lavori per l’approntamento della nuova fortezza presero avvio nel 1473, su progetto di Bartolomeo Gadio, per concludersi entro il 1475.
Con l’infeudazione del Conte Massimiliano Stampa del 3 novembre 1536, lo splendido manufatto militare venne progressivamente modificato e trasformato in castello per renderlo residenziale con alcuni interventi di decorazione pittorica pregevoli e fu realizzata la cappella ricavata nella torre di sud-est. Il fortilizio pervenne in stato di degrado al Comune di Soncino il 27 maggio 1876 per lascito testamentario di Massimiliano Cesare Stampa, 14° e ultimo marchese di Soncino.
Nel 1883, il Regio Ministero della Pubblica Istruzione incaricò l’architetto Luca Beltrami di progettarne il ripristino e il restauro. L’intervento del Beltrami rappresenta un esempio di ricostruzione condotto sulla base di una rigorosa documentazione storica.
Museo della Stampa Centro Studi Stampatori Ebrei
Il Museo della Stampa Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino, nato dalla volontà dell’Associazione Pro loco, fu inaugurato nel 1988 in concomitanza con le celebrazioni, organizzate per ricordare un evento memorabile, i 500 Anni della Stampa della Prima Bibbia Ebraica completa, avvenuta proprio a Soncino il 22 Aprile 1488, ad opera di una famiglia di ebrei provenienti da Spira, in Germania.
Intorno al 1490 gli Ebrei che ormai avevano assunto il cognome “Soncino” dovettero lasciare il nostro Borgo; l’attività di stampa continuerà a Barco di Orzinuovi, Brescia, Cesena, Rimini, Fano, Pesaro, Napoli, Salonicco e Costantinopoli.
Essi stamparono non solo in lingua ebraica ma anche opere in latino, in greco, in volgare italiano e perfino testi religiosi cristiani. Firmarono sempre le loro produzioni con il nome di SONCINO, quale segno di riconoscenza verso la città che li aveva accolti dopo la cacciata dalla Germania.
Gershom Soncino fu l’unico tipografo ebreo a stampare con mezzi propri, esercitando a cavallo di due secoli. Egli è considerato il più grande tipografo ebreo per la cura e la precisone compositiva dei testi e per la veste tipografica dei volumi.
Chiesa di San Giacomo
La chiesa di San Giacomo venne edificata nel XIV secolo sull'area di un antico ospizio per pellegrini, che continuò a funzionare fino al 1361. Dal 1361 al 1364 fu affidata ai canonici lateranensi di San Cataldo di Cremona che riuscirono a completare la torre campanaria, dall'insolita forma eptagonale (a sette lati).
Concessa ai domenicani, tra il 1456 ed il 1468 venne costruito il chiostro, ricostruita la zona absidale, la cripta ed il presbiterio sopraelevato. L'interno, a causa degli interventi sei e settecenteschi, si presenta in forme barocche.
Attraverso una scalinata si scende nella cripta della Santa Corona, costruita dopo il 1470 che ospitava la preziosa reliquia, ora nella chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare il presbiterio sopraelevato dove si possono ammirare due vetrate, opera di Fra Ambrosino de' Tormoli, e il coro ligneo in noce realizzato da fra Damiano Zambelli nel 1507-1508.
Attraverso un corridoio in fondo alla navata sinistra, si giunge in Sacrestia e da qui nel chiostro.
Chiesa di Santa Maria Assunta (Pieve)
La Pieve di S. Maria Assunta è situata in una tranquilla piazza posta dietro il Palazzo Pubblico. Secondo le fonti storiche, l'erezione di un primo edificio di culto a Soncino risale al V secolo. La chiesa attuale è il risultato di numerose trasformazioni, a partire dal XII secolo. Le aggiunte dei secoli XIV e XV non avevano intaccato in alcun modo la struttura romanica, mentre invece il rifacimento del 1580 mutò profondamente la struttura antica, in quanto dovette adattarsi alle nuove norme liturgiche stabilite dal Concilio Tridentino. In epoca tardo rinascimentale la chiesa venne interamente affrescata dai cremonesi Giulio Calvi detto il Coronaro (1585) ed Uriele Gatti, il quale, nel 1589, dipinse la controfacciata. L'epoca barocca lasciò tracce evidenti come l’allungamento del coro (1601-1615) e la costruzione delle cappelle laterali, mentre nel XIX secolo l'architetto Carlo Visioli edificò la cappella della SS. Trinità. Il terremoto del 1802 danneggiò seriamente la chiesa, tanto che intorno agli anni che vanno dal 1883 al 1888, il celebre architetto Carlo Maciachini la restaurò e la ampliò. Le navate e le cappelle meridionali furono conservate, come pure il campanile, mentre il muro settentrionale venne rettificato e la facciata venne riportata al suo presunto aspetto medioevale.
Chiesa Santa Maria delle Grazie
La chiesa sorge fuori città, sull’antica strada diligenziale che collegava Soncino a Cremona, sul luogo di un’antica cappella votiva quattrocentesca, ora visibile in parte nella seconda cappella di sinistra.La costruzione della Chiesa si deve ai frati carmelitani a partire dal 1501 per giungere a compimento nel secondo decennio del ‘500.La costruzione venne finanziata, inizialmente, dalle nobili famiglie Soncinesi e, dal 1527, dalla committenza del duca Francesco II Sforza e, poi, del marchese Massimiliano Stampa.
Vennero chiamati il pittore Francesco Scanzi per le cappelle laterali, Giulio Campi per la parte presbiteriale ed absidale e i fratelli Carminati da Lodi per la controfacciata, la volta e la seconda cappella di sinistra.
Nel corso della sua storia , la Chiesa visse una serie di vicissitudini: il trafugamento degli arredi sacri da parte di Ignazio Maria Fraganeschi, vescovo di Cremona, ed il bivacco napoleonico, alla fine del ‘700, il suo utilizzo come magazzino di munizioni, come infermeria e come fienile.Nel secondo '800 la contessa soncinese Costanza Cerioli, divenuta suora con il nome di Paola Elisabetta, acquistò il convento carmelitano, annesso alla chiesa, per la somma di 16.000 lire imperiali, e la chiesa riassunse la sua funzione originaria di luogo di culto.
Museo civico archeologico Aquaria
Il museo Civico archeologico "Aquaria" è ospitato all'interno della splendida cornice architettonica della Rocca sforzesca. Nato al fine di garantire un'adeguata collocazione alla ricca collezione che si è andata formando nel corso degli anni grazie alle raccolte di superficie del locale Gruppo archeologico Aquaria e alle indagini condotte dalla Sopraintendenza archeologica della Lombardia, il Museo ha una forte connotazione territoriale.
Il patrimonio archeologico attuale ammonta a diverse centinaia di reperti presentati attraverso un percorso cronolgico e tematico articolato in diverse sezioni, dalla Preistoria fino al XVII secolo inoltrato.
Torre Civica
La Torre Civica è il simbolo della Soncino medioevale, situata nella piazza centrale del capoluogo. Costruita nel 1128, è un edificio a canna quadrata di m. 5,95x5,95. Originariamente alta m. 31,50, fu innalzata nel 1575 a m. 41,80 con la costruzione della cella campanaria per ospitare il nuovo campanone. La scala di accesso in lato nord risale al primo '800. È inglobata su tre lati dal Palazzo Comunale. Il Palazzo che vediamo oggi è frutto di una serie di ricostruzioni, aggiunte e demolizioni dovute anche al terremoto del1802. Originariamente il Palazzo era composto dal Palazzo Vecchio (XII sec.); Palazzo dei Consoli (seconda metà del XII sec.); Palazzo del Podestà (XIII sec.); Palazzo Nuovo del Consiglio Generale (inizio XV sec.) con erezione della Torretta dei Matei. Oggi l'unica parte originale del Palazzo è l'ala in cotto con evidenti tracce delle aperture romaniche a bifora e la Torre Civica. Ancora oggi è possibile leggere il livello originario della torre attraverso gli elementi triangolari (merlature) poi tamponati con il sopralzo dell'anno 1575. ll frontone della facciata del Palazzo Comunale ricostruita a seguito del terremoto del 1802, con un timpano spezzato di gusto classicheggiante, è sormontato dalla torretta con un orologio a percussione (1506), costituito da due piccoli mori che battono con un martelletto su una campanella, testimonianza del periodo di dominazione veneta su Soncino. L'orologio fu un dono di Guido Contarini della Repubblica di Venezia. Si tratta di una riproduzione, in scala ridotta del celebre orologio di piazza San Marco. Le decorazioni in terrecotte dell'orologio astronomico risalgono al 1977 e sono opera degli scultori soncinesi Agostino Ghilardi e Fabrizio Pirletti
LA CELLA CAMPANARIA: Il castello campanario sovrasta le travi del tetto. Le campane, ingranaggi, motori e il castello campanario. La cella campanaria della Torre Civica è stata costruita nel 1575 a seguito dell'innalzamento della torre. Le campane sono tre e danno vita al "concerto a vivo" con il movimento simultaneo delle tre campane; il "concerto a morto" vede l'avvio in sequenza delle tre campane con il Campanone a distesa fino alla posizione a bicchiere, quindi seguono la Dovarese e la Campanella.
STRUTTURA INTERNA DELLA TORRE: La struttura della nuova scala a pianta quadrata realizzata con cosciali in ferro e pedate in legno, grazie alla tromba che si viene a creare, consente la lettura della torre, a canna quadrata, in tutta la sua verticalità. La risalita alla torre era consentita da una scala in legno, rimaneggiata nel corso dei secoli ai fini della manutenzione. La scala era inagibile da parecchi anni.
MANUTENZIONI ESEGUITE NEL TEMPO ALLA TORRE CIVICA
- L'orditura del tetto ad intervento compiuto (1966)
- L'armatura del tetto (1966)
- Il ponteggio del periodo (1966)
LE PRIGIONI EZZELINO III DA ROMANO - LA STORIA - Al primo piano, attigue alla torre, si trovano due celle carcerarie con la stanza del custode dove, secondo la tradizione, venne rinchiuso Ezzelino da Romano. Signore della Marca Trevigiana, fu politico e condottiero ghibellino, alleato di Federico II di Svevia. La famiglia degli Ezzelini o dei Da Romano giunse in Italia dalla Germania tra il X e XI secolo. Ezzelino III estese il suo dominio su Trento, Belluno, Vicenza, Verona, Bassano, Padova e Brescia, creando una sorta di signoria. L'imperatore Federico II di Svevia lo nominò Vicario Imperiale in Lombardia. Accusato di efferatezze e di eresia, nel 1254 fu scomunicato (i Papi, in quell'anno furono due: Innocenzo IV che terminava il mandato e Alessandro IV che iniziava il Pontificato nel mese di dicembre). Nel mese di marzo 1256 Azzo VII d'Este, podestà a vita di Ferrara, ricevette da Filippo, arcivescovo di Ravenna, l'incarico di condurre una "crociata" contro Ezzelino. Alla "crociata" parteciparono i soldati di Venezia, Bologna, Mantova, il conte di San Bonifacio e molti altri signori. Per ben due anni si trascinò pertanto una guerra di agguati e di mischie sanguinose, durante i quali Ezzelino III riuscì a impadronirsi di Brescia nel 1258. Le amicizie e le alleanze sulle quali Ezzelino III da Romano contava, gradatamente gli vennero meno Ghibellini e guelfi si trovarono così uniti. L'11 giugno 1259, Ezzelino passò l'Oglio e l'Adda con un forte esercito, per tentare di impadronirsi di Monza e di Trezzo. Il popolo milanese a sua volta rispose armandosi e andandogli incontro. Oberto II Pallavicino a capo dei cremonesi, il marchese d'Este a capo dei ferraresi e dei mantovani, si impadronirono di Cassano d'Adda e tagliarono ogni possibilità di ritirata a Ezzelino che fu sconfitto dopo una strenua battaglia il 16 settembre 1259 a Cassano d'Adda dalla lega guelfa di Azzo VII d'Este. In seguito alle gravi ferite riportate, venne catturato da Giovanni Turcazzano, capo dei militi Soncinesi e portato a Soncino dove spirò il 27 settembre, a 65 anni di età, rifiutando sacramenti e medicine. Una targa posta sulla facciata nord del Palazzo Comunale ricorda il luogo dove, secondo la tradizione, fu sepolto Ezzelino da Romano. Ogni mercoledì alle 8,45 il suono delle campane della Torre Civica rievoca l'agonia e la morte di Ezzelino III da Romano.
L'OROLOGIO: L'orologio della torre ha due quadranti disposti sui due lati opposti, un quadrante rivolto sulla piazza del Comune, l'altro sulla piazza della Pieve. Il loro funzionamento avviene a mezzo dei due motori installati all'interno della torre. Le lancette ed i numeri sono in lamiera colorata con smalto opaco, mentre il segno delle ore è dipinto sul quadrante. Con i lavori del 1966 venne eseguita la tinteggiatura dei quadranti, operazione che ha cancellato le linee dei minuti esistenti poi riemersi con il recente restauro.
LA MURATURA: Il paramento murario in cotto, interno ed esterno, presentava in svariati punti grave lacune con la totale perdita della stilatura dei giunti.
IL RESTAURO: I mattoni in cotto, gravemente scarnificati, sono stati ricostruiti con calci aeree e pozzolane prive di sali e finitura con tonachino coccio pesto.